
www.unimondo.org/Guide/Ambiente/Biologico/Storie-di-clima-205630
Storie di clima
Biologico
Stampa
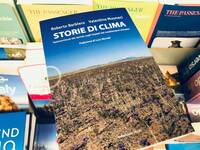
Foto: A. Graziadei ®
Ho appena finito di leggere l’ennesimo libro che ci parla di cambiamento climatico, ma a differenza di altri questo, oltre a spiegarmi bene perché la crisi climatica è ormai un’emergenza che non può più essere sottovalutata, mi ha fatto entrare in contatto con l’aspetto relazionale ed emotivo di questo problema. Sì, perché le “Storie di clima” raccontate per Ediciclo editore da Roberto Barbiero e da Valentina Musmeci sono quelle di donne e uomini che hanno un nome e nelle loro comunità, sparse in ogni parte del mondo, stanno già pagando caro il prezzo dei cambiamenti climatici. Sono persone che, a differenza della maggior parte di noi, per far fronte a questo pericoloso “cambio di stagione” hanno dovuto cercare nuove soluzioni per riuscire a sopravvivere. Si tratta di agricoltori, allevatori, attivisti, giornalisti, ricercatori che grazie ad organizzazioni non governative, associazioni, reti, gruppi organizzati o comunitari “hanno messo in moto forme di resistenza collettiva” che possono insegnaci molto e diventare buone prassi di resilienza climatica. Ho avuto la possibilità di intervistare Roberto Barbiero in occasione di un incontro on line con il Rotary Club Rovereto Vallagarina la scorsa settimana e ho provato a farmi raccontare alcune di queste storie, che come ricorda nella prefazione del libro il presidente della Società meteorologica italiana Luca Mercalli sono utili anche per non poter più dire “non credevo, non sapevo”.
Roberto grazie della disponibilità! La prima domanda riguarda il tuo ruolo di climatologo e di divulgatore scientifico. Olivier Burkerman, noto giornalista del Guardian, ha scritto: “Se una cricca di psicologi malvagi si fosse radunata in una base sottomarina segreta per ordire una crisi che l’umanità sarebbe stata irreparabilmente impreparata a fronteggiare, non avrebbe potuto escogitare di meglio dei cambiamenti climatici”. Il nostro sistema di “allarme” non sembra fatto per le minacce concettuali. Se escludiamo Vaia, che nel 2018 ci ha dato, almeno per un po’, una prova tangibile di che cosa significa la tropicalizzazione di un territorio alpino, da giornalista ho capito che l’emergenza climatica non è una storia facile da raccontare e, soprattutto, non è “buona storia”. Non spaventa troppo, non affascina tanto, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare il nostro stile di vita. Riflettere sulla complessità e sulla varietà delle minacce che il cambiamento climatico comporta sembra spossante e la mole di informazioni si perde in un grande ronzio di sottofondo. Ti chiedo: la crisi climatica potrà mai diventare una “buona storia” prima che sia troppo tardi?
Per rispondere ad una domanda del genere forse è necessaria un’analisi sociologica più che quella di un fisico studioso del clima! Posso dare solo qualche spunto di riflessione a partire dalla mia esperienza personale. Una “Buona storia” implica il racconto di quanto sta accadendo in maniera tale da rendere appetibile, conveniente e desiderabile il cambiamento che si rende necessario. Ritengo che siano necessari alcuni ingredienti per raccontare una buona storia. Occorre innanzitutto far prendere consapevolezza del problema, del fatto che riguarda la mia vita e quella delle persone che vivono nella mia comunità. Serve poi immaginare e far percepire il possibile miglioramento della propria vita. Infine è utile far veder che ci sono degli strumenti a disposizione per portare avanti questo cambiamento. Raccontare delle storie concrete va in questa direzione: far vedere con degli esempi persone che hanno toccato con mano il problema, ne hanno preso coscienza, hanno messo in campo soluzioni o strumenti per fronteggiarlo e hanno ottenuto dei miglioramenti è molto utile. Come ricorda del resto il premio Pulitzer Dan Fagin, che cito nell’introduzione del libro “Abbiamo i fatti, abbiamo la conoscenza, abbiamo perfino le soluzioni. Ma i fatti non bastano a rendere le persone consapevoli dei cambiamenti climatici. Le persone non credono alle cifre, ai dati e ai grafici. Abbiamo bisogno di ottenere la loro piena attenzione e di farci capire. Per questo dobbiamo creare una storia”.
Ecco perché in “Storie di clima” abbiamo scelto di raccontare delle storie concrete che ovviamente non sono favole e mostrano come questi percorsi implichino fatica. Tutte le storie fanno esperienza di relazione come strumento indispensabile. Il nodo centrale, che emerge in molte storie, ed è ben sottolineato nell’ultimo numero di Altreconomiadall’antropologo Van Aken, è la rottura del rapporto essere umano e ambiente che lo circonda. Van Aken scrive: “il cambiamento climatico è il prodotto della relazione eccezionale che la società occidentale ha avuto con l’ambiente concependolo come comparto a sé, esterno all’essere umano”. “Buona storia” è far percepire che ciò che si cerca è ricostruire questa indispensabile relazione dell’essere umano con l’ambiente che lo ospita. Camminare in un prato e sentire il profumo dei fiori è o no diverso dal camminare per una strada di asfalto sentendo rumori e odori di scarico? Dove ci sentiamo meglio?
Io non ho tanti dubbi davanti a questi interrogativi e penso pochi di noi potrebbero averli, eppure, per usare le parole dello scrittore Amitav Ghosh nel libro “La grande cecità”, “La crisi climatica è anche una crisi della cultura, e pertanto dell’immaginazione” se non addirittura della capacità di credere. Pensi che l’incapacità di credere fino in fondo a questa minaccia sia più legata alla poca voglia di ripensare il nostro stile di vita e l’attuale sistema economico che lo sostiene o alla nostra incapacità di capire e talvolta credere nella scienza?
Ci sarebbero tante cose su cui riflettere, lancio qualche sasso. Innanzitutto va chiarito che la scienza del clima, quella seria, è compatta: il cambiamento climatico che osserviamo è qualcosa di anomalo nella storia recente del pianeta in termini di accelerazione del riscaldamento globale e dei conseguenti impatti. Le cause sono attribuite al ruolo antropico e in particolare alle emissioni di gas serra provenienti da settori che riguardano produzione e consumo di energia (trasporti, industrie, riscaldamento/raffreddamento) e di cibo. Vero è che la scienza spesso non è stata capace di rapportarsi con il mondo politico e l’opinione pubblica: il tema è complesso, la comunicazione può non risultare efficace e forse non sempre vengono usati gli strumenti adeguati. Tutto ciò è oggetto di discussione e riflessione. Esiste anche un problema di basso livello culturale, dobbiamo ammetterlo: troppe persone non hanno gli elementi base per seguire anche concetti relativamente semplici, non sono in grado di capirli. Attenzione però, lo scarso livello culturale non sempre ci basta a spiegare questa mancanza di fiducia. Una recente indagine negli USA ha osservato che il divario tra negazionisti e non negazionisti aumenta con il crescere del livello culturale e con la polarizzazione tra elettori repubblicani e democratici. Cioè conta di più lo schieramento politico e il preconcetto iniziale. In questo caso quindi occorre tenere conto anche degli effetti della disinformazione in tema di cambiamenti climatici che nel caso degli Stati Uniti ha giocato un ruolo determinante.
Per affrontare queste problematiche credo che occorra un enorme sforzo educativo e di onesta e corretta informazione che faccia percepire e capire la stretta relazione tra il sistema economico e il nostro stile di vita con il cambiamento climatico. Occorre interrompere la narrazione dell’inganno che ci porta ad inseguire dei desideri indotti, mai soddisfatti, piuttosto che dei bisogni reali. Questa rincorsa dei desideri ha ridotto persone e ambiente a merce. Guai a chi ferma questa corsa. Per impedire che ci siano ostacoli alla corsa e per garantire il nostro stile di vita basta far emergere continui nemici e alimentare la paura verso di loro: che siano gli stranieri o l’Unione europea poco importa! Occorre quindi rompere l’inganno narrativo che tutela un modello economico che garantisce l’accumulo di ricchezze a quell’1% della popolazione mondiale responsabile del doppio delle emissioni di CO2 prodotte dal 50% più povero, che va sempre più alla deriva. Infine è bene essere chiari: posso anche oppormi e non mettere in discussione il mio stile di vita, ma dovrò fare i conti presto con la sua insostenibilità sociale e ambientale. La natura ci sta già presentando il conto.
Come dici tu “Forse non sempre vengono usati strumenti adeguati” per raccontare il cambiamento climatico. Questo libro, invece, fa del dibattito sul “Climate change” qualcosa di meno astratto. Per farle sentire ancora più vicine ad un territorio come quello della Vallagarina ti chiedo partire dalla storia di Barbara ed Enzo e della loro vite “che non piange più”.
Siamo a Rovescala sulle colline dell’Oltrepò Pavese, dove Barbara ha dato vita al progetto che sognava da tempo: coltivare viti e avviare un’azienda di produzione di vini, nel rispetto di un territorio e di una cultura millenaria, affiancando a questa attività quella di apicoltore del compagno Enzo. Dall’esperienza di Barbara tante cose stanno cambiando tra queste viti. Complessivamente le piogge diminuiscono, ma aumentano i fenomeni di piogge intense e brevi. Dal 2013 si osservano fenomeni di siccità continua, con le piante che sono già in sofferenza in primavera. “Negli ultimi anni ciò che sta creando problemi a noi agricoltori sono le rapide e diverse anomalie meteorologiche”. Che fare? Dopo aver puntato sulla qualità più che sulla quantità, curando le viti più vecchie e il loro patrimonio di biodiversità e superato i pregiudizio di genere “essere donna in ambito agricolo è penalizzante. Si fatica tre volte tanto, specie nel settore viticolo”, Barbara cerca di fare rete, ma non sembra una cosa facile da realizzare: “Ci sono 900 abitanti a Rovescala e circa 50 aziende vitivinicole. Eppure lavorare insieme sembra un miraggio. Rete riesco a farla con le persone ‘straniere’ e io, che non sono originaria di queste terre e sono considerata tale”. In questi anni ha avviato una rete di produttori di vino biologico, cercando di promuovere un marchio collettivo di qualità e di organizzare eventi progettati insieme, per moltiplicare le competenze e le esperienze individuali e dal 2014 ha inserito la sua azienda in un circuito che mette in contatto le fattorie biologiche con chi voglia, viaggiando, fare esperienza di vita rurale. Il suo sogno, pensando alle relazioni, è fare come le api di Enzo, capaci con uno sforzo comunitario di mantenere un ecosistema naturale e biodiverso, anche se le api, come le viti, sono in sofferenza. Il 2019 è stato l’apice di una serie di annate critiche che si susseguono, specie per la siccità che non consente ai fiori di svilupparsi e di dare nettare. Per Enzo “Un problema che senza dubbio emerge è la perdita di sincronismo tra la fioritura e la necessità di alimentazione delle api. Purtroppo si osserva che oltre a non dare a sufficienza nettare, e quindi miele, si rende necessario mantenere le api artificialmente. Se non ne hanno abbastanza bisogna dar loro sostanze zuccherine non salutari visto che non sarebbe il loro nutrimento naturale”. Enzo è piuttosto pessimista e teme che se continueranno annate così calde l’apicoltura non darà più reddito e bisognerà trovare delle alternative. La sua proposta? “A questo punto gli apicoltori che svolgono il loro lavoro a servizio della collettività non dovrebbero essere solo sostenuti, ma retribuiti. Se davvero le api diminuiranno sarà un immenso problema per tutti”. Forse Enzo ha ragione, retribuire gli apicoltori potrebbe essere una misura di adattamento ai cambiamenti climatici. Forse tra le più efficaci.
Tra queste storie di clima mi ha colpito anche la storia di Andrea. Zoologo, responsabile del settore ricerca scientifica ed educazione ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta. Andrea non è solo il testimone del ritiro dei nostri ghiacciai e “portavoce” di chi, come gli stambecchi, ha rinunciato con l’evoluzione alle ghiandole sudorifere, confidando nel freddo perenne del loro habitat, ma è anche un attore di un altro aspetto fondamentale per affrontare il cambiamento climatico, cioè la ricerca, non solo dei problemi, ma anche delle soluzioni.
Per Andrea la chiave interpretativa più importante per comprendere le dinamiche ambientali che ha osservato in questi ultimi anni è proprio quella dei cambiamenti climatici. Secondo lui “Gli effetti del riscaldamento globale sulla natura delle Alpi a volte sono evidenti, basti pensare alla riduzione dei ghiacciai, facilmente interpretabile da chiunque anche solo osservando la situazione attuale e confrontandola con vecchie fotografie e cartoline”. Ma non è sempre così! Andrea è convinto che spesso gli effetti del cambiamento climatico siano subdoli, difficili da percepire “come fossero una malattia che nelle fasi iniziali manifesta pochi sintomi, quasi nascosti anche al medico più bravo, per poi manifestarsi con violenza all’improvviso”. Quello che sta osservando Andrea è che la velocità di estinzione, ovvero la perdita di biodiversità, è molto alta a causa delle modificazioni globali indotte dall’uomo sul pianeta e nettamente maggiore rispetto alla nascita di nuove specie. “Se quest’ipotesi è vera, se cioè la velocità della perdita dovesse essere nettamente maggiore a quella della capacità della natura di sopperire ad essa… bè, allora possiamo comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi”. Già nel rapporto del 2016 “Climate change, impacts and vulnerability in Europe”, firmato dalla European Environment Agency, venivano messe in evidenza alcune caratteristiche degli impatti delle regioni alpine caratterizzate da un tasso di riscaldamento superiore alla media globale sella stessa Europa: la diminuzione dell’estensione del volume dei ghiacciai, lo spostamento in quota di specie animali e di piante, l’alto rischio di estinzione di specie, l’aumento del pericolo di malattie nelle foreste, l’aumento del rischio di frane e smottamenti per l’intensificarsi di eventi meteorologici estremi e il degrado del permafrost, “sono tutti effetti che possiamo confermare”. Per comprendere gli effetti e le possibili strategie di conservazione utili a far fronte ai cambiamenti climatici il Parco Adamello Brenta sta investendo da tempo in attività di ricerca, in particolare ha ideato un vasto progetto pluriennale, denominato BioMiti, che si propone di studiare gli equilibri ecosistemici negli ambienti di alta quota e le possibili modificazioni legate ai cambiamenti climatici, nel tentativo di trovare misure idonee a una sempre migliore salvaguardia degli ambienti naturali.
Oggi parlare di cambiamenti climatici significa anche parlare di diritti umani calpestati e ingiustizie subite. Ve lo ha raccontato bene la giovanissima giornalista spagnola Ana Nieves, che si sta occupando con un programma radiofonico del problema delle migrazioni connesse ai cambiamenti climatici. Come si collegano nell’esperienza di Ana questi due fenomeni?
Con il suo lavoro Ana ci ricorda che “i fattori che costringono la gente a migrare sono molto complessi e storicamente sempre legati ad aspetti politici, persecuzione ideologica e/o conflitti e ad aspetti socio-economici, come l’aspettativa di migliorare le proprie condizioni di vita. Tuttavia l’impatto dei cambiamenti climatici dovuto in particolare alla siccità e alle inondazioni sta diventando un fattore sempre più importante. I cambiamenti climatici, infatti, possono ridurre la produttività agricola e influire negativamente sulla resa delle culture, ma riducono anche la disponibilità di acqua e incidono sulla salute delle persone, e a lungo andare potrebbero forzare gli spostamenti transfrontalieri”. Una vicenda esemplare è quella delle lavoratrici marocchine occupate ogni anno nella raccolta delle fragole in Andalusia che impiega circa 70.000 braccianti per più di tre mesi all’anno tra fine febbraio e giugno. Le lavoratrici migranti addette alle fragole (in maggioranza marocchine, ma ci sono anche rumene e polacche), raccolgono ogni anno 250.000 tonnellate di fragole contribuendo ad un fatturato di circa 320 milioni di Euro. Un settore strategico per la Spagna, ma in sofferenza a causa della delicata gestione dell’acqua sempre più difficile da utilizzare nei campi a causa di sistemi di irrigazione intensivi e fatiscenti oltre che per via delle sempre più frequenti ondate di calore e siccità che colpiscono il sud della Spagna. Le braccianti fanno i conti con salari da miseria, sistemazioni in baracche di cartone e plastica, inosservanza delle norme in materia di rischi sul lavoro, oltre che essere spesso vittime di abusi sessuali. Chi ha denunciato pubblicamente le violenze, rompendo il muro di omertà e connivenze, ha dovuto subire anche il rifiuto dei mariti e delle famiglie di origine che le hanno ripudiate. “Il mio paese - ricorda Ana - vive con una doppia morale: pone problemi nell’accoglienza degli stranieri, ma nel contempo consente l’entrata stagionale con permesso a migliaia di persone ogni anno, per garantire la raccolta nei campi”. Le storie di molte di queste lavoratrici (che vivono in modo simile ai migranti che in Italia contribuiscono alla raccolta delle arance in Calabria o dei pomodori in Puglia) stanno smascherando le menzogne che partiti xenofobi e di estrema destra cavalcano da anni additandole come colpevoli di portare via il lavoro ai locali, lavoro che nessuno spagnolo farebbe mai. “Credo che serva un investimento in cultura, informazione ed educazione se vogliamo che le cose cambino” ci ricorda Ana che crede nella forza dell’informazione, anche per sensibilizzare ed educare i consumatori che con scelte più responsabili e consapevoli possono fare molto anche per i diritti dei lavoratori e non solo per il clima.
Grazie Roberto. Nel libro, che spazia dalla Sicilia al Libano, arrivando fino ai nativi americani Navajo dell’Arizona e ai Sami della Lapponia, che combattono contro il cambiamento climatico e lo sfruttamento delle loro terre anche grazie alle loro conoscenze indigene, raccontate decine di storie personali che si innestano in risposte comunitarie. L’impressione che ne ho avuto è che alla fine il “clima siamo noi” con le nostre scelte. Citando il saggista americano Jonathan Safran Foer autore di “Possiamo salvare il mondo prima di cena”, uno dei più recenti e interessanti libri sul clima: “Nessuno se noi distruggerà la terra e nessuno se non noi la salverà. Noi siamo il diluvio, noi siamo l’Arca”. Ti chiedo come uomo e come scienziato se i “noi” che hai incontrato scrivendo questo libro ti hanno dato speranza e in caso quanta.
Certo, mi hanno dato molta speranza. Sono storie costruite dal basso. Storie di tante donne che soffrono le maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici, ma stanno mettendo in campo le soluzioni più originali e di giovani che non si spaventano davanti al cambiamento. Sono storie di leadership credibili che hanno saputo costruire reti e gruppi organizzati per cercare anche di contaminare la politica. Non è possibile infatti pensare di fermarci a cambiamenti solo individuali. Le soluzioni, che per essere veramente efficaci dovrebbero diventare sempre collettive e politiche, sono del resto note. Non ci sono impedimenti fisici alla riduzione delle emissioni di gas serra e la tecnologia disponibile sarebbe già di grande aiuto, ma c’è bisogno di una volontà politica che deve trovare uniti tutti i Paesi in uno sforzo immane di cooperazione e di responsabilità. Purtroppo questa volontà politica manca così come la consapevolezza che le risorse del pianeta sono limitate e abbiamo poco tempo a disposizione per cambiare direzione! La natura reagirà e si adatterà, anche se alcune specie scompariranno, ma le comunità umane rischiano molto di più, sono fragili in realtà. Su quest’aspetto mi preoccupa la cecità della politica e l’egoismo degli interessi di parte.
Non cambiare non è un’opzione, a meno che non si voglia lasciare alle future generazioni non solo un debito economico, ma anche un debito ecologico insanabile. Tuttavia provo a concludere con una riflessione scomoda e ti chiedo come faremo a “cambiare il mondo”? Il petrolio oggi è ancora il fondamento di interi sistemi economici e per chi basa i propri profitti su questo settore e su altri altamente inquinanti, una riconversione non è semplice. Ci sono in gioco milioni di posti di lavoro e gli interessi di lobby potentissime. Nel 2050 poi, sulla terra saremo quasi 10 miliardi e solo per nutrire e soddisfare i bisogni di tutti dobbiamo aspettarci un aumento delle emissioni. Insomma, come faremo?
Il problema che dobbiamo capire è che l’emergenza ci costringerà a cambiare! La pandemia ne è solo un esempio. Sta a noi prepararci o lasciarci travolgere. Non esistono ricette facili ma le azioni da mettere in campo sono evidenti: occorre una modifica strutturale del sistema economico e finanziario, come delineato nel piano conosciuto come Green New Deal; occorre riscrivere il rapporto con il naturale: ciò non implica solo un cambiamento economico ma anche culturale (l’occidente deve mettersi in discussione). Occorre anche recuperare il ruolo e la centralità degli Stati che devono condurre una “giusta transizione, “Just transition”, accompagnando ad esempio i lavoratori dei settori che saranno più penalizzati. Si deve poi capire che non c’è giustizia climatica se non c’è giustizia sociale: il ruolo delle donne, il rispetto dei diritti umani, la tutela dei popoli indigeni e della loro cultura, sono aspetti centrali per risolvere il problema del clima. Dobbiamo essere molto realisti e prepararci anche ad inevitabili conflitti perché non saranno pochi coloro che si opporranno a porre un limite ai propri vantaggi anche e in contrasto con la salvaguardia del pianeta. Infine serve un nuovo approccio metodologico nuovo: dobbiamo imparare ad avere un approccio femminile nella cura del pianeta e delle relazioni tra persone. Mi è sempre piaciuto in questo senso il gioco di parole usato dalla poetessa Gioconda Belli nel suo libro “Nel paese delle donne” dove le donne giunte al potere hanno trasformato i cittadini, “ciudadanos” in spagnolo, in “cuidadanos”, dal verbo “cuidar”, avere cura, e quindi in persone che devono avere cura della propria comunità e delle quali occorre prendersi cura come amministrazione politica.
Grazie mille Roberto per il tuo tempo e per le tue preziose riflessioni che ci ricordano che le soluzioni, anche se non facili o scontate, esistono. Personalmente come andrà a finire non lo so, ma credo che se come dici tu riusciremo a mettere in discussione a livello globale e in modo radicale la nostra idea di “sviluppo scorsoio” la sfida non è persa, neanche a livello economico. I cambiamenti climatici hanno ricadute enormi sul Pil mondiale ed è sicuramente meglio governare questo cambiamento anziché subirlo. Gli scienziati hanno calcolato che, per creare un nuovo sistema energetico globale e rinnovabile, nel corso dei prossimi decenni occorrerebbe investire il 2,5% del Pil mondiale. Impossibile? Per mandare 4 uomini sulla luna il 20 luglio del 1969 gli americani hanno devoluto per 10 anni esattamente il 2,5% del loro Pil. Sappiamo come è andata a finire. In tutto il mondo il contributo medio investito nella difesa ed in sistemi di armamento ammonta all’incirca al 2,5 % del Pil. Non esiste ancora nessun esercito o cannone che ci possa difendere dal cambiamento climatico, ma sappiamo che un investimento di questa portata è possibile anche oggi. I precedenti e le opportunità, insomma, ci sono, non coglierle significherebbe sacrificare in modo consapevole il futuro delle prossime generazioni.
Alessandro Graziadei

Sono Alessandro, dal 1975 "sto" e "vado" come molti, ma attualmente "sto". Pubblicista, iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2009 e caporedattore per il portale Unimondo.org dal 2010, per anni andavo da Trento a Bologna, pendolare universitario, fino ad una laurea in storia contemporanea e da Trento a Rovereto, sempre a/r, dove imparavo la teoria della cooperazione allo sviluppo e della comunicazione con i corsi dell'Università della Pace e dei Popoli. Recidivo replicavo con un diploma in comunicazione e sviluppo del VIS tra Trento e Roma. In mezzo qualche esperienza di cooperazione internazionale e numerosi voli in America Latina. Ora a malincuore stanziale faccio viaggiare la mente aspettando le ferie per far muovere il resto di me. Sempre in lotta con la mia impronta ecologica, se posso vado a piedi (preferibilmente di corsa), vesto Patagonia, ”non mangio niente che abbia dei genitori", leggo e scrivo come molti soprattutto di ambiente, animali, diritti, doveri e “presunte sostenibilità”. Una mattina di maggio del 2015 mi hanno consegnato il premio giornalistico nazionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue “Isabella Sturvi” finalizzato alla promozione del giornalismo sociale.












