
www.unimondo.org/Guide/Ambiente/Conservazione/Sardegna-zone-umide-e-la-proposta-di-un-turismo-consapevole-217821
Sardegna, zone umide e la proposta di un turismo consapevole
Conservazione
Stampa
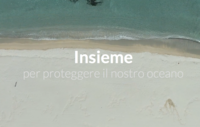
Foto: Medseafoundation.org
Le Regioni italiane si stanno dando parecchio da fare per promuovere il turismo estivo. È una sfida a cui molte non sono state granché abituate, perché in qualche modo non ne hanno avuto bisogno. La bellezza dei luoghi parlava da sola.
Quest’ultimo anno, abbondante di restrizioni e solitudini, ha però determinato una situazione critica da molteplici prospettive: non solo economiche, con le conseguenze che sappiamo derivanti dalle chiusure e dalle limitazioni imposte ad alcuni settori più che ad altri, ma anche per la diffidenza che si è diffusa rispetto agli spostamenti, alle condizioni di sicurezza igienico sanitarie, alla possibilità incerta di poter visitare luoghi e Paesi diversi dal proprio con la serenità e la leggerezza con cui si era abituati a farlo. Eppure lo sappiamo, anche se non possiamo dare per certi il come e il quando, torneremo a viaggiare, e magari questa volta potremo provare a farlo con maggiore consapevolezza e attenzione, soprattutto in quelle zone che fino ad ora ci hanno attirato per altri motivi.
Una delle Regioni che meriterebbe uno sguardo rinnovato è la Sardegna. Spettacolari spiagge di quarzo e svaghi di lusso accessibili a pochi potrebbero affiancarsi a un turismo diverso, più lento e sostenibile, sul quale puntare per far conoscere l’isola per altre eccellenze, come per esempio quella della tutela della natura e dell’economia locale nella provincia di Oristano. Qui, in circa 50 km di costa, si trovano sei zone umide di rilevanza internazionale. Della tutela di questo santuario “diffuso”, abitato da oltre cento specie di uccelli – tra cui fenicotteri, volpoche, gru europee –, si occupa il progetto Maristanis, esperienza modello per quelle aree ricche di biodiversità terrestre e marina (come per esempio le foreste di posidonia) che però subiscono la pressione di attività economiche con cui non è facile stabilire regole di convivenza: si pensi a turismo, pesca e agricoltura e ai rispettivi potenziali impatti, che dipendono ovviamente e sempre da modalità e intensità con cui queste attività vengono svolte ma con le quali è necessario fare comunque i conti. Altrettanto sensibile è il rapporto con gli insediamenti umani negli spazi lagunari.
In un video di poco più di 2 minuti Giorgio Massaro, esperto ambientale della Fondazione Medsea, riassume la bellezza e la fragilità di questi habitat, come per esempio quello dello stagno di Sal’e’Porcus (San Vero Milis), uno tra i 6 siti Ramsar (Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale) della provincia di Oristano, prezioso per la presenza e la nidificazione di uccelli soprattutto nel periodo invernale.
Maristanis è un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano, cofinanziato dalla Fondazione MAVA e coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", che si sviluppa in parallelo ad altri tre progetti cofinanziati da MAVA in Tunisia, Montenegro e Albania. Lo scopo è quello di affrontare sfide incalzanti come un efficiente utilizzo delle risorse idriche, la tutela delle specie protette e degli habitat, la valorizzazione del patrimonio culturale, la coesistenza con le attività agricole e con la pesca e l’avvio di progetti pilota a supporto dell’economia del territorio e delle zone umide costiere. Gli attori, diversi e molteplici per caratteristiche e competenze, hanno sottoscritto il Contratto delle Zone Umide marino-costiere dell’oristanese, esito di un processo partecipato in cui sono intervenuti, insieme ai conservazionisti e alle istituzioni, anche i rappresentanti dei settori produttivi, delle associazioni locali e delle imprese turistiche e pensato proprio per potenziare istanze di conservazione discusse con il territorio, che fossero invece frutto di soluzioni condivise per l’elaborazione di modelli virtuosi.
Un’esperienza faticosa avviata nel 2017 che sta cominciando a dare risultati e che può proporsi come esempio ripercorribile in altre realtà della penisola per valorizzare il patrimonio italiano sia da un punto di vista naturalistico che economico e produttivo, difendendo il territorio e al contempo creando occupazione, puntando sul recupero della tradizione e dei suoi manufatti e su un turismo che promuova attività di mobilità alternativa e di riscoperta di quella ricchezza che troppo spesso diamo per garantita, senza interrogarci sul futuro.
Anna Molinari

Giornalista freelance e formatrice, laureata in Scienze filosofiche, collabora con diverse realtà sui temi della comunicazione ambientale. Gestisce il progetto indipendente www.ecoselvatica.it per la divulgazione filosofica in natura attraverso laboratori e approfondimenti. È istruttrice CSEN di Forest Bathing. Ha pubblicato i libri Ventodentro (2020) e Come perla in conchiglia (2024). Per la testata si occupa principalmente di tematiche legate a fauna selvatica, aree protette e tutela del territorio e delle comunità locali.












