
www.unimondo.org/Guide/Informazione-e-Cultura/Educazione-allo-sviluppo/Costruire-ponti-e-coltivare-giardini-199638
Costruire ponti e coltivare giardini
Educazione allo sviluppo
Stampa
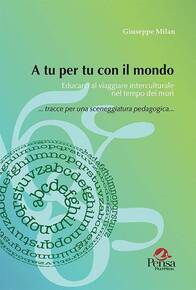
Copertina del libro "A tu per tu con il mondo"
Nel contesto odierno è sempre più difficoltoso l’incontro con l’altro. Ad ogni livello. Nella dimensione globale, dopo l’illusione di 30 anni fa con la caduta del muro di Berlino, da qualche anno invece che alla progressiva cooperazione tra i popoli e gli Stati, assistiamo al ritorno fortissimo dei nazionalismi, alla politica di potenza con la nuova corsa agli armamenti, alla sfiducia reciproca. Persino la lotta ai cambiamenti climatici e alla pandemia, quest’ultima un pericolo attuale e concretissimo, non ha unito gli abitanti e i governanti del pianeta ma ha accentuato il “si salvi chi può”.
Nella dimensione piccola, locale e individuale, l’altro è sempre più il concorrente se non direttamente il nemico. Ci “contagia”. Viene a rubarci il lavoro. Porta via la nostra identità anche se non sappiamo più che cosa esso sia. L’altro ha il volto dello straniero, del migrante. Ma pure i legami più stretti, tra quanti vorrebbero condividere lingua, cultura, antenati, affetti e destino, sono fragili, instabili a volte finiscono per diventare sterili, inutili. Anche in questo caso siamo spinti a cavarcela da soli, in solitudine.
In questo contesto come si fa a credere di poter entrare in confidenza con il prossimo e con il mondo, stare “A tu per tu con il mondo”?
Eppure proprio questo è il titolo dell’ultimo volume, edito quest’anno da Pensa MultiMedia, di Giuseppe Milan, ordinario di pedagogia interculturale e sociale all’Università di Padova. Proprio nel contesto di una modernità arida, secondo la felice espressione coniata da Milan qualche anno fa che ribalta il concetto di modernità “liquida” coniato da Bauman, occorre il coraggio di pensare all’interculturalità di offrire nuovi stimoli per il futuro. Di immaginare e delineare orizzonti ampi, grandi traguardi a cui tendere. È il momento di credere ancora di più, quando tutto sembra dire il contrario, al valore del dialogo, dell’ascolto, dell’incontro tra diversi. Puntare agli ideali di bellezza e di fraternità. Solo questo ci può salvare.
Il volume in questione, scrive l’autore, è “una specie di palinsesto pedagogico, un percorso di riflessione e ricerca con tappe (…): prevede un punto di partenza, un punto d’arrivo e un itinerario da percorrere che comprende movimento e sosta” (13). È un invito al viaggio. Non a caso il sottotitolo è esplicito in tal senso: “Educarci al viaggiare interculturale nel tempo dei muri”. Come l’educazione anche il viaggiare è un’arte. Per questo l’autore mette in guardia da un certo tipo di cosmopolita che “può assumere le sembianze di un individualista eccentrico e supponente, che si gloria di amare e possedere il mondo, spesso dal chiuso della propria camera, altre volte come effettivo viaggiatore ed esploratore dei continenti – ma all’interno dell’asettica e aristocratica appartenenza ad un mondo esclusivo” (35).
Essendo poi Milan attento anche ai risvolti artistici, l’itinerario da lui proposto si snoda attraverso alcuni “atti” e alcune “scene”. Piano piano il sipario si apre e il palcoscenico, all’inizio vuoto, si anima di personaggi prima soli e poi capaci di abitare la scena insieme con gli altri. È un cammino di riconoscimento del diverso e quindi di se stessi perché, se siamo capaci di guardare oltre la consuetudine, viene prima il tu dell’io. Anzi l’Io-Tu, seguendo la filosofia dialogica di Martin Buber (autore su cui Milan ritorna spesso), formano una coppia inscindibile, la relazione originaria.
La parte più interessante del volume riguarda le indicazioni costruttive che Milan offre al lettore: circostanza rara e preziosa perché è molto più semplice descrivere la triste realtà piuttosto che dare soluzioni percorribili e appassionanti. Occorre puntare in alto. Per esempio, per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza globale, il pedagogista ci avverte che non basta più la cittadinanza sia globale e attiva, dovrebbe essere anche responsabile, solidale, ospitale, fraterna.
Per prima cosa è necessario riuscire ad abitare i luoghi. Riprendendo Heidegger, Milan scrive: “l’uomo si fa, si autentica, si realizza nell’abitare, nell’assumere uno spazio e nel dargli forma” (27). Però non si può abitare da soli, bisogna entrare in contatto con l’alterità: “crediamo che l’affermazione heideggeriana “l’uomo esiste in quanto abita” possa essere arricchita dalla seguente: l’uomo abita in quanto è abitato. È o, meglio, può essere un abitante abitato. Abitato proprio dalla relazione autentica, dall’alterità che non resta confinata nell’extra – in tal caso permanendo in una sorta di naufragio – ma che senza perdere nulla della sua alterità, della incommensurabile distanza propria della relazione autentica, può farsi ospite interno, tu interno” (98).
I passaggi non sono scontati. Chi è l’Altro per te? chi sei tu per l’Altro? Questa è la domanda decisiva. Da come si risponde a tale quesito scaturisce l’opzione etica fondamentale su cui orientare la propria vita (75). L’altro può essere belva, ospite, fratello.
“Lo straniero ci risulta, allo stesso tempo, enigmatico e straordinario. È una provocazione che ci pone di fronte alla radicale alternativa: fissarci ancora di più nella piattaforma esistenziale-culturale del conformismo, nella comfort zone, oppure avere il coraggio di uscire dall’ordinarietà per inoltrarci negli spazi sconfinati e inquietanti della meraviglia. Ma la straordinarietà ci spaventa o sollecita il desiderio? La vediamo come nemica o come compagnia da custodire e amare?” (86).
Su questo terreno si gioca il senso dell’interculturalità: è sovversiva, arricchente, difficile (Panikkar), richiede un “dialogo denso” (Charles Taylor) ma non significa negazione o squalifica del proprio contesto culturale. “Significa piuttosto – come afferma Fornet Betancourt – assumere un atteggiamento positivamente critico nei riguardi della propria cultura, della propria storia, delle proprie tradizioni che vanno invece intese come punto di appoggio antropologico dal quale partire per procedere verso più ampie esperienze e modalità di comunicazione reciproca” (105).
Non bisogna distruggere la propria identità ma da lì partire per gettare ponti. Scrive ancora il pensatore cubano: “La nostra cultura potrebbe essere così intesa come il ponte che non possiamo saltare ma che dobbiamo attraversare se vogliamo arrivare dall’altra parte” (54). E noi dobbiamo andare dall’altra parte.
La visione della relazione con l’altro proposta da Milan si estrinseca nella metafora del giardino. Pagine splendide a cui rimandiamo disegnano una prospettiva davvero affascinante. Sintetizzando con una sola citazione: “il luogo giardino ricorda perciò una relazionalità, un equilibrio estetico sottoposto ad un attento accompagnamento: il giardiniere ha il compito di mantenere in vita e di rispettare una progettualità significativa, senza la quale la crudeltà del tempo può distruggere la costruzione culturale e abbandonare tutto alle intemperie, alla vita vegetativa, al fluire dell’ingovernabile” (95). Per far vivere e prosperare un giardino armonioso occorrono coltivazione, custodia, protezione, manutenzione, cura, capacità di sorprendersi, amore.
Giungiamo così all’atto terzo di questa performance educativa-politica. Nella prima scena Milan propone un “decalogo” pedagogico, dieci parole chiave o principi pedagogici che l’autore considera come le “dimensioni strutturali dell’educazione che vanno considerate strettamente interconnesse sia sul piano teorico sia nell’operatività: l’educazione viene qui intesa come sinergica compresenza di tali dimensioni fondanti che dovrebbero compenetrarsi e sostenersi reciprocamente” (119). L’autore si serve di un particolare metodo pedagogico-didattico, il service-learning (o apprendimento-servizio), che prevede la sinergia dinamica e imprescindibile di apprendimento e servizio, di pensiero e azione, di compito scolastico-accademico e compito sociale-contestuale-ambientale. Così, ogni apprendimento non è a se stante ma ha conseguenze operative (azioni utili al contesto) e ogni azione non è mera azione ma richiede e arricchisce l’apprendimento. Per esempio, raccogliere le immondizie lungo un fiume è mero servizio; studiare in laboratorio campioni d’acqua è apprendimento; rilevare campioni d’acqua da un fiume per evidenziare il grado di inquinamento e organizzare un’azione di purificazione – possibilmente in collaborazione con le istituzioni locali – è apprendimento-servizio (service-learning).
In un’intervista del 19 luglio scorso apparsa sul settimanale padovano “La Difesa del popolo”, il professore spiega bene alcune delle sue parole. “Problematicità, ci dice che nulla è scontato e precostituito, che dobbiamo essere sempre ricercatori; responsabilità, rappresenta l’idea forte nei rapporti tra di noi nel mondo che ci è consegnato, ci vuole capaci di risposta all’appello del mondo e degli altri; reciprocità, spiega come evitare la concezione di una comunicazione unilaterale e che la parola è ascolto, collaborazione, gioco del dialogo; la creatività ci toglie da un mondo dove siamo meri esecutori e costretti a un conformismo ripetitivo per consegnarci alla dimensione del gioco, della fantasia; la temporalità, ci consente di dare importanza con la stessa profondità a presente, passato e futuro perché noi siamo questa articolazione temporale; la socialità, in un tempo in cui c’è molta prassi narcisistica, ci porta a credere alla socialità come dimensione fondamentale del vivere. La sistematicità, ci consegna il lavoro a rete, le progettualità condivise a tanti livelli, e la scuola diventa emblematica quale sistema di rapporti che servono per migliorare insieme”.
Nella parte conclusiva del volume Milan sostanzia le tre fasi di dell’arte del viaggio, dell’ospitalità (“l’arte di invitare – l’arte di andare a trovare – l’arte di sostare”) in dieci passi o atteggiamenti concreti necessari per affinare la propria sensibilità e per consentire effettivamente l’incontro. Allestire l’ambiente, autenticità, umiltà, contatto, accettazione, empatia, rispetto, lotta, conferma, fiducia: ecco le dieci stazioni.
Moltissimi aspetti sarebbero da evidenziare. Lasciamo al lettore l’approfondimento. Ma un cenno all’empatia e alla fiducia occorre farlo. L’empatia oppure, secondo Buber, “fantasia reale” è lo snodo centrale dell’itinerario, l’atteggiamento decisivo perché “La costruzione dei suddetti ponti, capaci di collegare aspetti, tempi, persone, età, culture, mondi diversi, nel suggestivo gioco tra realtà e fantasia, tra adesione al dato e spinta all’utopia, è particolarmente urgente e impegnativa nell’ambito interculturale e della migrazione in genere, al quale appartengono persone per le quali il “passaggio” è un modo di essere nel quale tuttavia non devono perdersi ma ritrovare se stessi” (157).
Infine la fiducia, vincolo indispensabile di vita, energia generativa, collante comunitario è l’esito finale ma anche il presupposto per giungere a una relazione reciproca autentica perché fondata su una polarità speculare e su un intimo riconoscimento delle parti. Così “l’altro è colui che ci permette di esistere, di ritrovarci, di camminare nel percorso esistenziale che ci attende con la certezza di essere accompagnati per mano e di poterci affidare a questa compagnia fedele che ci dà forza, ci sostiene, ci spinge in avanti” (173).
Alla fine di questa lettura si è spinti per davvero a cominciare questo itinerario. Che sia possibile incontrare nell’altro e nell’altro popolo un ospite, una compagnia, un collega, un fratello? Non resta che provare
Piergiorgio Cattani

Nato a Trento il 24 maggio 1976. Laureato in Lettere Moderne (1999) e poi in Filosofia e linguaggi della modernità (2005) presso l’Università degli studi di Trento, lavora come giornalista e libero professionista. Scrive su quotidiani e riviste locali e nazionali. Ha iniziato a collaborare con Fondazione Fontana Onlus nel 2010. Dal 2013 al 2020 è stato il direttore del portale Unimondo, un progetto editoriale di Fondazione Fontana. Attivo nel mondo del volontariato, della politica e della cultura è stato presidente di "Futura" e dell’ “Associazione Oscar Romero”. Ha scritto numerosi saggi su tematiche filosofiche, religiose, etiche e politiche ed è autore di libri inerenti ai suoi molti campi di interesse. Ci ha lasciati l'8 novembre 2020.











