
www.unimondo.org/Guide/Ambiente/Contaminazioni/Da-Campania-Felix-a-Terra-dei-fuochi-262338
Da Campania Felix a Terra dei fuochi
Contaminazioni
Stampa
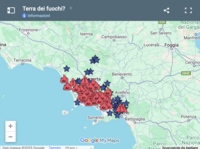
Foto: Google.com
Il 20 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano per aver agito troppo lentamente e in maniera inefficace nel tutelare il diritto alla vita della popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Si tratta di un’area vasta più di 1.000 km e che copre 57 comuni tra il Nord di Napoli e il Sud di Caserta. Il territorio è abitato da circe tre milioni di persone che, per decenni, sono state esposte a sostanze contaminanti derivanti dallo smaltimento illecito dei rifiuti. Questa esposizione ha avuto impatti gravissimi sulla salute, portando a un aumento vertiginoso delle percentuali di ospedalizzazioni e morte per tumori e altre patologie.
Nonostante ampie fasce della popolazione abbiano denunciato per decenni la contaminazione e le sue conseguenze sanitarie, per troppi anni – ha affermato la sentenza della CEDU – la politica è stata incapace di rispondere. Nella sentenza la Corte arriva a stabilire una data a partire dalla quale l’Italia era sicuramente consapevole di quello che accadeva – il 1988 – e un metodo di omissione di intervento: il segreto di stato sulle dichiarazioni dei pentiti del clan dei Casalesi che raccontavano il metodo di smaltimento illegale perseguito per decenni.
Nella terra, nelle acque superficiali e di falda, e nell’aria della Terra dei Fuochi ci sono sostanze velenose per gli organismi: metalli pesanti ma anche amianto, benzopirene, cloruro di vinile, diossina. Sostanze che, a contatto con gli organismi umani, ne danneggiano in DNA in maniera irreversibile, rendendolo più fragile e predisponendolo a tumori, problemi nelle gravidanze e malformazioni congenite, malattie tiroidee e patologie cardiovascolari e come patologie metaboliche correlate direttamente o indirettamente alla tumoregenesi.
Le sostanze che stanno avvelenando i cittadini campani provengono da diverse fonti. Innanzitutto lo smaltimento illegale di rifiuti perpetuato per decenni dai clan: un sistema triangolare che ha visto la collaborazione tra imprenditoria corrotta, spesso proveniente dal Nord Italia, camorra, in particolare con gli esponenti del clan dei casalesi, e politica, con amministratori troppo a lungo silenti. Per incompetenza, complicità, corruzione, come ha stabilito la magistratura attraverso diverse inchieste. Ditte di dubbia provenienza reclutavano imprenditori che, dall’altra parte del Paese, affidavano loro lo smaltimento dei propri rifiuti pericolosi senza fare domande sul dove e come avvenisse e, soprattutto, senza chiedere e chiedersi perché il servizio arrivasse a costare anche meno della metà di quanto costava nelle loro regioni. I fusti di rifiuti venivano caricati su camion che tornavano verso Sud, in Campania, dove venivano interrati nella zona tra Napoli e Caserta e tombati in gabbie di cemento.
Lì avrebbero dovuto restare per sempre e nel segreto ma da lì si sono mossi, le sostanze si sono sprigionate contaminando i terreni, percolando nelle acque di falda e liberandosi nell’aria. Sono arrivate nel cibo coltivato, negli animali allevati, nei corpi delle persone. In poche decenni la stessa area, prima chiamata Campania Felix, era la Terra dei fuochi. Fuochi per i roghi tossici che si liberavano dai rifiuti. Anche da quelli di altra provenienza: gli scarti industriali di fabbriche e fabbrichette distribuite nell’hinterland napoletano. Buchi neri, scantinati, dove avvenivano produzioni di scarpe e accessori che, con un “giro di bolla” tornavano nell’economia legale e nelle vetrine dei grandi marchi. Accessori venduti a migliaia di euro, prodotti per pochi spiccioli da lavoratori a nero di imprese formalmente inesistenti. I cui rifiuti speciali, dunque, non potevano essere smaltiti in circuiti legali.
Che i fumi di quei fuochi facessero male alla salute la popolazione campana lo ha denunciato per decenni. Lo ha fatto nell’indifferenza delle istituzioni, che negli anni hanno risposto alla fitta rete di comitati e associazioni prima negando il problema, accusando medici e scienziati di allarmismo; poi minimizzandolo, legandolo allo stile di vita della cittadinanza. Mentre si bruciavano sostanze velenose a cielo aperto, mentre dal terreno si sollevavano le fumarole della combustione spontanea degli inquinanti tossici, Ministri dell’Ambiente, sindaci, Presidenti del Consiglio e della Regione suggerivano agli abitanti della Terra dei Fuochi di condurre una vita meno sedentaria, mangiare cibi più salutari e non esagerare con grassi, fumo e bevande alcoliche.
All’inizio degli anni ’10 del 2000 le indagini della squadra del Generale Sergio Costa – divenuto poi Ministro dell’Ambiente – hanno consentito una mappatura dettagliata di tutti i siti di interramento: una cartina dell’orrore che ha mostrato ai cittadini campani che, da decenni, vivevano letteralmente sopra una enorme discarica di rifiuti tossici e nocivi. Nel 2013 sono arrivate anche le dichiarazioni dei pentiti del clan che, alle telecamere di giornali e tg, hanno raccontato del business dei rifiuti e, soprattutto, del silenzio imposto dalle istituzioni per trent’anni. Da questa congiuntura è derivata una grande mobilitazione che ha riacceso le attività delle diverse centinaia di comitati e associazioni, che per mesi hanno organizzato manifestazioni quotidiane, marce, presidi, assemblee e proteste in tutti i singoli comuni colpiti, culminati nel corteo del 16 novembre 2013, il cosiddetto Fiume in Piena che ha portato più di 100mila persone per le strade di Napoli.
Da quella stagione e grazie all’attivazione di comitati e tante e tanti singoli è nato il decreto Terra dei Fuochi, che interviene in tutta Italia sullo smaltimento illecito dei rifiuti, ma in Campania è cambiato molto poco. Le bonifiche sono pressoché ferme, così come gli screening sanitari richiesti a gran voce dalla popolazione, le cui ragioni ancora oggi sono suffragate unicamente da due studi. Il primo si chiama Veritas, è un biomonitoraggio indipendente condotto per volontà e grazie all’impegno dei comitati ambientalisti che ha coinvolto l’esperienza progettuale dell’associazione nazionale A Sud, un laboratorio di analisi privato e indipendente e lo Sbarro Institute di Philadephia, un centro di ricerca genetica sulle malattie oncologiche diretto da Antonio Giordano, un oncologo e genetista di origini napoletane. Il progetto ha ricercato e dimostrato la presenza di metalli pesanti derivanti dai rifiuti nel sangue e nei fluidi corporei dei pazienti oncologici della Terra dei Fuochi. Proprio questo studio, condotto tra il 2017 e il 2018, sarà citato tra le fonti della Cedu.
La seconda ricerca è stata presentata nel 2021 e realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità su mandato della Procura di Napoli Nord. Lo “Studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord” analizza solo una parte dei 57 Comuni, dove mappa 2.746 siti di smaltimento dei rifiuti di cui il 90% è illegale. In quelle discariche abusive, scrivono i ricercatori, ci sono sostanze e materiali che la letteratura scientifica connette all’insorgere di specifici tumori, leucemie e problemi respiratori, ma anche malformazioni congenite e nascite pretermine. Il 37% della popolazione locale vive a meno di 100 metri da uno o più siti.
Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità è un’anomalia: è la prima volta che un ente istituzionale riconosce apertamente la relazione tra malattie e rifiuti per i cittadini campani, e lo fa mentre i medici di base denunciano un aumento delle patologie non ancora censito dai Registri Tumori territoriali perché troppo recente. Questo accade in una regione in cui il servizio sanitario è al collasso: la seconda per mobilità sanitaria interregionale d’Italia. Sembra la ricetta di un disastro perfetto. E lo è, come sanno i comitati che da anni lo denunciano e che oggi vogliono ripartire, anche dalla sentenza della Cedu, per riaccendere uno dei conflitti ambientali più gravi d’Italia.
Su questo tema è in edicola, a marzo 2025, una lunga inchiesta su Il Salvagente che analizza nel dettaglio la situazione.
Rita Cantalino

Napoletana, classe ‘88. Freelance, collabora con diverse testate. Si occupa di ambiente, clima e diritti umani, con uno sguardo particolare agli impatti sanitari e sociali delle contaminazioni di natura industriale.











