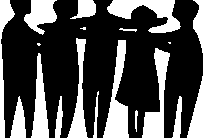www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace/Conflitti/Israele-Palestina-la-guerra-dell-acqua-160361
Israele – Palestina: la guerra dell’acqua
Conflitti
Stampa
Dal 21 al 23 Settembre, la città di Venezia ha ospitato la fiera WATEC, un incontro principalmente business to business tra aziende che si occupano di tecnologie idriche. La fiera nel Pala Expo di Marghera, visitabile comprando un biglietto dal costo di circa 100 euro, è stata organizzata dalla società Israeliana Kenes Exhibition. E’ la prima volta che l’evento si tiene in Europa: nato a Tel Aviv, WATEC ospita molte aziende israeliane che sono in prima fila nella realizzazione e nella vendita di tecnologie idriche, dalla gestione delle acque reflue alla desalinizzazione dell’acqua.
Tra queste, l’azienda statale israeliana Mekorot, una delle dieci aziende dell’acqua più potenti al mondo. La Mekorot nacque nel 1937, ovvero 11 anni prima della nascita dello Stato di Israele. Già questo è un dato importante, che fa riflettere sull’esistenza di un progetto politico a lungo termine per la costruzione di uno stato, legato anche al controllo dell’acqua. Come la stessa azienda riconosce nel proprio sito web, l’acqua è un bene fondamentale, una “condizione essenziale per la vita”. Proprio questo è uno dei punti di partenza dell’intervento di Renato Di Nicola- del forum italiano dei movimenti per l’acqua- nel corso dell’incontro “H2Occupation”, che si è tenuto a Venezia Lunedì 19 Settembre. A questo evento hanno partecipato anche Amira Hass, giornalista israeliana per il quotidiano Haaretz e per Internazionale, e Stephanie Westbrook, rappresentante del movimento BDS (Boycott, Divestment,Sanctions).
“H2Occupation” nasce in risposta alla fiera WATEC di Venezia, per sensibilizzare circa la situazione idrica in Israele e Palestina. Infatti, da decenni si assiste ad un vero e proprio processo di espropriazione delle risorse naturali palestinesi, nello specifico in questo caso delle risorse idriche, a favore dello Stato di Israele.
La giornalista Amira Hass, osservando il pubblico con aria greve, ha descritto la situazione a partire dai dettagli più piccoli, e al tempo stesso, più evidenti: “Come posso distinguere una casa palestinese da una israeliana? Ebbene, una casa palestinese avrà sempre un serbatoio d’acqua, nero e cilindrico, sul tetto, al contrario di quella israeliana. Inoltre, se una casa è circondata da un giardino verde e rigoglioso, si tratterà di una casa israeliana; non perché a noi israeliani piaccia di più la clorofilla, ma perché i palestinesi dispongono di una quota di acqua, oltre la quale i rubinetti rimangono secchi”, spiega la Hass, che vive da 25 anni a Ramallah, la capitale amministrativa della Cisgiordania. Amira è un esempio estremamente isolato di cittadina israeliana che vive in Palestina: “Godo dei privilegi di essere israeliana e di essere giornalista, per questo non ricevo troppe pressioni dalle autorità israeliane”, spiega. Da vent’anni, ogni estate la Hass scrive sulla crisi dell’acqua in Palestina “anche se preferirei non chiamarla crisi”, dice, “perché la crisi è qualcosa di isolato e temporaneo, mentre qui siamo di fronte ad un processo continuo e sempre più grave”.
Infatti, al momento i palestinesi dipendono quasi totalmente da Israele per l’erogazione dell’acqua. Ai tempi del Mandato Britannico in questa zona, era possibile trasferire l’acqua dalle sorgenti alle zone più secche. Oggi invece, la Palestina è divisa in tre zone (A, B e C), dove la zona C è controllata dall’amministrazione israeliana, che non autorizza la costruzione di tubi per l’acqua da una zona all’altra della Cisgiordania. In base agli accordi di Oslo del 1993, la distribuzione di acqua tra israeliani e palestinesi è stata divisa rispettivamente all’80% e 20%, che oggi si è ridotta alla proporzione 86 e 14 poiché i pozzi palestinesi aperti nella zona loro assegnata- ad Est del Monte Aquifer- non si sono rivelati così ricchi d’acqua, al contrario della zona assegnata ad Israele ad Ovest del monte. Questi accordi, che dovevano essere temporanei, sono tutt’ora in vigore.
Il monte Aquifer è una delle tre principali sorgenti d’acqua della zona: le altre due sono il fiume Giordano, e la falda acquifera presente lungo la costa di Gaza. Per quanto riguarda la Valle del Giordano, 28 dei 48 pozzi israeliani in Cisgiordania si trovano in questa zona: la Mekorot produce circa 30 milioni di metri cubi d’acqua l’anno da questi pozzi, contro un totale di 109 metri cubi d’acqua l’anno estratti dai pozzi palestinesi in West Bank, per un totale di 2,4 milioni di abitanti della Cisgiordania.
Gaza, poi, è un discorso a parte: qui vivono 1,8 milioni di persone, che possono usare una quantità d’acqua che nel 1951 veniva utilizzata da 270 mila persone. Questo porta al fenomeno dell’over pumping, un sovra-pompaggio d’acqua che ha fatto abbassare la falda acquifera sotto il livello del mare, inquinando l’acqua con sale ed acque reflue. “I miei amici di Gaza che possono permetterselo, lavano i propri figli con l’acqua minerale, il che ovviamente ha un costo altissimo”, osserva Amira Hass. Si prevede che la falda potrebbe esaurirsi nel prossimo futuro, e nessuno può immaginare quali conseguenze catastrofiche questo potrebbe avere per la popolazione di Gaza, già stremata per la mancanza di elettricità, materie prime e medicinali. Gli attacchi israeliani alle infrastrutture per la produzione di energia elettrica a Gaza, da ultimo il bombardamento della centrale che produce i 2/3 del fabbisogno elettrico della zona, nel 2014, rendono “ridicolo il progetto per un impianto di desalinizzazione dell’acqua , quando le persone non possono nemmeno accendere una lampadina la sera”, commenta la Hass.
Le autorità israeliane, quando interrogate su questo tema, rispondono che i palestinesi mentono: mentono sulla demografia palestinese, sull’esistenza di una crisi idrica e per di più, spesso rubano l’acqua. “E’ vero, c’è chi si attacca ai tubi illegalmente: ma sono tubi palestinesi, quindi la quantità d’acqua totale prevista per la popolazione araba non cambia”.
Infine, Giovanni Fassina, giovane avvocato praticante, ha parlato del Joint Water Committee, un comitato congiunto tra autorità israeliane e palestinesi fondato con Oslo, che doveva servire a prendere decisioni comuni in tema di risorse idriche. Invece, il suo funzionamento a consensus, ha portato ad una tale sproporzione nel potere decisionale che l’Autorità Palestinese ha smesso di parteciparvi. “Secondo il diritto internazionale umanitario la potenza occupante non può utilizzare le risorse naturali della popolazione occupata, sulla base della Convenzione dell’Aja del 1907 e della Convenzione di Ginevra del 1949. Molte risoluzioni ONU chiedono ad Israele di cessare quella che sembra essere una vera e propria razzia delle risorse idriche palestinesi”, spiega Fassina.
Per questo, molte associazioni tra cui l’ARCI e i sindacati FIOMM- Cgil e USB, hanno firmato l’appello che chiede alla Commissione Europea di ritirare il proprio patrocinio per la fiera WATEC, poiché molte delle aziende che ne fanno parte contribuiscono ad una grave condizione di oppressione. Come ha sottolineato Di Nicola, bisogna tener presente che l’acqua viene oramai concepita come un prodotto, piuttosto che come un bene essenziale. Principale causa di questa mercificazione dell’acqua, è la tecnologia: “Bisogna rompere la narrazione che vuole la tecnologia come qualcosa di neutro, di scollegato al contesto politico dove nasce e dove viene applicata”,spiega.
Varie aziende italiane hanno concluso degli accordi con Mekorot, tra cui il colosso romano ACEA nel 2014 e la partecipata Metropolitana Milanese nel 2016; inoltre, ci sono stati incontri tra la società e la Regione Abruzzo nel 2016. In particolare, la Westbrook, attivista nella campagna No Mekorot, spiega: “Virginia Raggi, neo-sindaca di Roma, in veste di consigliera comunale aveva firmato un’interrogazione sulla Mekorot della quale potrebbe e dovrebbe oggi tenere conto”.
La questione israelo-palestinese divide, e spesso ci si impone di essere imparziali o ascoltare le due voci, capire le ragioni delle due fazioni coinvolte nel più lungo conflitto del nostro pianeta. “Quando si tratta dell’acqua però, noi israeliani non possiamo più addurre ragioni di sicurezza a giustificazione delle nostre azioni”. Inoltre, Amira Hass ad Unimondo chiede: “Sareste stati equidistanti, nel parlare della situazione dei neri in Sudafrica durante l’apartheid?”.
Leggi Amira Hass e i suoi reportage sull’acqua su Haaretz, Internazionale e Nena News.
Sofia Verza

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, ha studiato ad Istanbul presso le Università Bilgi e Yeditepe, specializzandosi nel campo del diritto penale e dell'informazione. Ad Istanbul, ha lavorato per la fondazione IKV (Economic Development Foundation), ricercando nel campo della libertà di espressione. E' stata vice presidente dell'associazione MAIA Onlus di Trento, occupandosi di sensibilizzazione sulla questione israelo-palestinese e cooperazione culturale in Cisgiordania. Scrive per il Global Freedom of Expression Centre della Columbia University e collabora con Osservatorio Balcani e Caucaso.