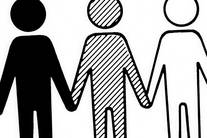www.unimondo.org/Guide/Economia/Fundraising
“Il fundraising è la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare”. (Henry Rosso)
Introduzione
Il fund raising ha radici antiche. Anche in civiltà e contesti storici lontani, nel tempo e nello spazio, è emersa la necessità e l’opportunità di coinvolgere soggetti della società civile nel miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Infiniti sono gli esempi. L’antico codice ebraico della Tzedaqà - una raccolta di insegnamenti e regole sul valore degli atti di bontà, giustizia e beneficenza - annovera la possibilità di sollecitare i donatori. Nel IV secolo a.C., i Greci raccoglievano fondi avvalendosi di “sottoscrizioni”, così come avveniva 2.000 anni fa all’epoca dell’impero romano.
Un altro momento d’oro è poi l’epoca del Rinascimento e del Mecenatismo quando lo Stato, cioè il sovrano, sosteneva arte, cultura, scienza oltre ad attività di assistenza alla popolazione. Una tradizione plurisecolare, legata alle istituzioni caritative, che in Italia si è espressa per la prima volta in realizzazioni sociali e raccolte di fondi in settori come la sanità e la scuola. Nel medioevo e in epoca moderna le attività di beneficenza, sanità e istruzione, hanno costituito i principali filoni di intervento delle istituzioni caritative, un patrimonio collettivo con un indiscusso valore pubblico: accoglienza dei pellegrini, cura degli infermi, iniziative a favore di orfani e vedove, ospedali, carcerati. Molte di queste realtà sono cresciute nel corso dei secoli e sono tuttora attive.
L’Ottocento in particolare si caratterizza come il secolo dell’affermarsi di esperienze di autotutela, con l’istituzione di società di mutuo soccorso, la nascita di banche popolari e casse rurali e iniziative nel campo dell’istruzione scolastica e professionale. Proprio nella seconda metà del XIX secolo però le istituzioni statali iniziano a estendere la loro influenza in tutti gli ambiti della vita civile, sottratti progressivamente all’iniziativa e alla responsabilità di privati ed enti.
Gli interventi legislativi dello Stato, che si susseguono negli anni prima e dopo l’unità d’Italia e, in particolare, dopo la Seconda guerra mondiale, mirano a eliminare una parte considerevole delle organizzazioni operanti nel sociale. Questo interventismo statale in vari settori sociali ed economici ha contribuito a smussare l’impulso del donatore a contribuire alle aziende nonprofit. Ciò non significa però che lo Stato sia riuscito a soddisfare tutte le esigenze sociali. Dopo un prolungato periodo di rafforzamento del welfare state, si è giunti, intorno ai primi anni Settanta in Italia, alla crisi della tradizione solidaristica e a una progressiva ripresa del mondo del volontariato e del “non profit” che da allora a oggi è cresciuto ed ha assunto un nuovo ruolo sociale.
Da questa evoluzione derivano connotati e caratteristiche odierne del fund raising “made in Italy”. Come sottolinea Stefano Zamagni “L'Italia possiede una matrice culturale che mai è stata favorevole ad attività di raccolta fondi, in quanto il suo ordine sociale è stato dominato negli ultimi due secoli dalla figura centrale dello Stato. È proprio allo Stato, e più di recente all'ente pubblico locale, che il cittadino italiano medio affida le sorti del proprio benessere. In un simile contesto, il modello secondo cui soggetti della società civile raccolgono fondi a favore di altri soggetti della stessa società è lontano dalla concezione comune. Ciò spiega perché l'Italia presenta tutt'oggi la percentuale più bassa di rapporto tra popolazione e contribuzione volontaria, in relazione ad altri paesi occidentali avanzati”.
Sebbene i più riconducano all’Europa e alle istituzioni ecclesiali la nascita del fund raising (la raccolta fondi per uno scopo sociale), lo sviluppo più intenso di questa disciplina si è avuto negli Stati Uniti. Qui ha preso le mosse la prima scuola di fundraising, quella nata dal pensiero di Henry Rosso. L’attività del fundraising concepita e strutturatasi in maniera sistematica e scientifica, già operativa da oltre un secolo in America, in Italia si è via via affermata da circa una ventina dì anni e ancora conosce molta diffidenza e reticenze.
In tempi di crisi
Prassi rodata all’estero, anche in Italia il fundraising si sta ritagliando un ruolo sempre più strategico, quale strumento indispensabile per l'autonomia e la crescita dell'economia civile. Ogni “buona causa” necessita di nuove risorse. La crisi del welfare e dell’intervento pubblico in tandem con la recessione non fanno che catalizzare questa esigenza, puntellata dalla crescita dei bisogni sociali e della competizione sempre più accesa fra realtà del settore.
Le criticità della congiuntura economica mondiale oltreoceano , come in Europa, sembravano non aver intaccato la raccolta fondi. Anche in Italia inizialmente non si è avvertito alcun colpo di arresto, come testimonia una ricerca condotta dall'Istituto Italiano della Donazione nel gennaio 2009, intitolata "La generosità batte la crisi? Le elargizioni da privati al Terzo Settore" e focalizzata sull’analisi dell’andamento delle donazioni nel periodo natalizio.
Nella seconda rilevazione, effettuata nel giugno 2009, si inizia però a rilevare l’impatto negativo della crisi economica sulle organizzazioni no profit e sul Terzo Settore: su un campione di 100 organizzazioni, per più di un terzo di esse hanno previsto perdite ingenti. Proprio nel momento in cui gli economisti hanno iniziato a prevedere timide riprese, si rabbuia l’orizzonte del settore del No Profit, per il quale le donazioni rappresentano linfa vitale. I dati di percezione tracciano un panorama più nero di quanto non ci si aspettasse, con un 34% delle Onp che denunciano forti perdite nella propria attività di Fund Raising.I dati più preoccupanti dalle realtà che lavorano per la lotta all'esclusione sociale, cooperative e onlus i cui target sono cittadini disabili, donne, migranti e, in generale, quelle categorie sociali vittime di disagio e emarginazione. Al contrario le perdite minori si registrano per quelle organizzazioni che si occupano di tutela della salute come prevenzione o ricerca scientifica.
É in questo momento che il fund raising assume ancora più valore come scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale, conseguenza degli obiettivi e dei benefici sociali che un’organizzazione intende raggiungere.
Fundraising e reciprocità
Alla base della moderna cultura del dono e del fund raising c’è Ken Burnett, altro guru a stelle e strisce che sintetizza l’attività in “gestione efficace ed efficiente dei legami fra un’organizzazione e soggetti (individuali e collettivi) presenti nell’ambiente in cui essa opera: esso è principalmente “relationship fundraising”. Gli fa eco Valerio Melandri, fundraiser e direttore del Master in fund raising dell’Università di Bologna, secondo cui il fund raising è “ciò che l’organizzazione fa per creare rapporti di interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane e chi è potenzialmente disponibile a donarle”.
La interazione che si ingenera afferisce alla categoria dell’interesse reciproco, del matrimonio di interessi, dello “scambio” sociale. A differenza dello scambio di beni equivalenti, tipico delle imprese profit, e di quello redistributivo, tipico degli enti pubblici, si tratta di uno scambio di reciprocità. Così come teorizzato da Zamagni, si tratta dell’insieme di attività economiche e sociali che si basano sul principio di reciprocità. Il principio in questione “fa riferimento ad una relazione, una transazione o un’interazione particolare, che consiste in una serie di trasferimenti bilaterali, indipendenti, liberi tra loro e in qualche modo interconnessi”.
Nel contesto della dimensione relazionale, ossia tutto ciò che in un’interazione economica le due parti apportano reciprocamente di non misurabile, di non contrattabile, ma di personale e non di meramente strumentale. Le relazioni diventano quindi un bene, “prodotto” e “consumato” secondo finalità civili: conta il modo in cui il bene viene fornito e consumato ai fini della creazione di utilità. Fra gli esempi relazionali più classici: l’abitudine a ritrovarsi in certe occasioni, la familiarità esistente all’interno di gruppi di amici o di parenti, la comunanza di esperienze, la conoscenza reciproca, la fiducia che si instaura tra persone, e soprattutto lo scambio generato dal meccanismo di fund raising dove il donatore devolve risorse e l’organizzazione non profit non restituisce un bene equivalente, ma esclusivamente un bene relazionale (ringraziamento, amicizia, appartenenza) unito, a volte, a un bene economico materiale di valore simbolico (come una tessera di socio, una notazione, una qualche forma di pubblicità indiretta).
Modalità e strategie
Nel recente consolidamento del fund raising sotto il profilo scientifico, come disciplina professionale, modelli e tecniche di origine anglosassone sono state innestate e tarate sulle necessità del mondo della cultura, dell’etica e del terzo settore. Numerose e variegate sono le strategie per coinvolgere privati, imprese o fondazioni bancarie. Nessuna regola fissa in questo universo, avverte anche Ken Burnett, “ma alcuni principi basilari fondamentali e utili virtualmente in qualsiasi intervento di fund raising”. Fra i suoi suggerimenti, cinque assunti fondamentali da ricordare riguardo ai potenziali finanziatori:
a) i donatori in genere sono generosi e sono attenti alla gente;
b) sono intelligenti;
c) si aspettano di essere trattati con gentilezza;
d) sono individui, con interessi, abitudini e risposte differenti;
e) è più probabile che rispondano meglio quando ricevono da noi ciò che vogliono ricevere, piuttosto che ciò che non vogliamo che essi abbiano”.
Alla radice di un piano fund raising efficace un’ analisi e progettazione finalizzata a individuare il migliore modello adottabile da un’organizzazione in relazione alla proprie caratteristiche. Così come illustra Coen Cagli, esperto in strategie di fund raising, nel “Manuale di fundraising: la raccolta fondi per le organizzazioni non profit”, sono chiari i passaggi base di ogni piano che si rispetti: coinvolgimento e analisi dell’organizzazione; analisi dell’ambiente (opportunità e minacce, trend generali, soggetti e relazioni con i finanziatori; progettazione e pianificazione (definizione singole attività e scelta strumenti); messa in opera (staff, monitoraggio, gestione degli aspetti finanziari, contabili e fiscali); valutazione del piano e gestione degli esiti (analisi economica, valutazione potenzialità, fidelizzazione, rinnovo e incremento); revisione del ciclo (riformulazione di alcuni suoi presupposti e avvio di un nuovo ciclo).
Gli strumenti
Fitto il ventaglio di soluzioni per la raccolta fondi. Dalle più tradizionali - come il tesseramento, il merchandising (la vendita diretta di gadget, attività di forte impatto e guadagno immediato contante), eventi (finalizzati alla raccolta fondi o alla promozione pubblicitaria) e la creazione di partnership con imprese del profit attraverso sponsorizzazioni o cause related marketing (acquisto di un prodotto con una parte dell’incasso devoluto alla organizzazione) - ad altre più recenti.
Fra queste il direct mailing (invio di lettere presso un elenco di donatori o potenziali tali) o il telemarketing. In quest’ultima categoria rientrano, per esempio, le donazioni tramite invio di SMS, tecnica che fa leva per lo più su ondate emotive, dove il coinvolgimento è occasionale. Fra le tecniche di origine estera, anche il face to face in cui degli operatori - da noi chiamati “dialogatori” - illustrano in un contatto diretto, in genere per strada, le attività sostenute dall’ organizzazione e propongono di sostenere la causa con una donazione mensile con domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. La tecnica adottata in Austria negli anni ’90 da Greenpeace, si è poi sviluppatasi in tutta Europa, fino ad attecchire anche in Italia negli ultimi anni.
Le frontiere di Internet
Le nuove tecnologie sul web stanno rendendo Internet un media sempre più caldo. Sebbene il donatore prediliga ancora il contatto personale, il web come canale di donazione è in fase di crescita. Soprattutto grazie alla nascita del 2.0, infatti è in grado di ripetere, in nuove modalità, forme di relazione personale più tipiche del vecchio mercato, della piazza o della stradina di provincia che non della comunicazione broadcasting tipica della TV o delle forme più tradizionali di direct marketing.
Una grande lezione in questo senso è stata offerta recentemente dal sito e dagli strumenti messi in campo dallo staff di Barack Obama nella campagna elettorale che ha portato alla sua elezione, come mette in evidenza Paolo Ferrera nel suo blog FundraisingNow, dedicato alle nuove opportunità offerte dal 2.0 al settore. Innumerevoli gli strumenti partoriti per il web e recentemente adottati anche in Italia: aste on line, virtual gift catalog, online merchandising, fundraising events, adesioni e rinnovi on line, pay per click, donazioni pianificate, pixel fundraising, partnership aziendali.
Ultimo, in ordine di tempo, ma non di potenzialità, l’approdo ai social media come facebook e twitter, grazie alla facilità con cui mettono in relazione le persone, come spiega nel suo blog Marc A. Pitman, fundraiser e autore del libro “Ask Without fear”.
Una prova del ruolo assunto da Internet in questo campo - come illustra Francesco Santini su Fundraising.it - è offerta dalla repentina mobilitazione anche italiana di siti web, social network (Facebook e Twitter in testa) ed e-mail per la raccolta fondi a favore della popolazione di Haiti colpita dal violento terremoto del 12 gennaio 2010.
Questione di fiducia
Il fund raising, di pari passo con il management delle organizzazioni non profit, si sta professionalizzando, portando a un miglior impiego delle risorse, a soluzioni più strategiche ed efficaci. Una evoluzione che può contribuire a stimolare la donazione, purché non si prescinda da una condizione antica: il fattore fiducia.
Condizione sine qua non fondamentale, già citata nella Carta Caritatis del 1098, pubblicata da San Bernardo di Chiaravalle, come mette in luce Zamagni, il primo documento del fundraising e comprende una lista di regole relativamente alla raccolta fondi. Dopo la prima regola che chiarisce che i soldi non si danno a chi ne ha bisogno, ma a chi dimostra di saper soddisfare il bisogno, il documento parla di accountability e prevede che il beneficiario mostri l'uso che ha fatto dei fondi. Pietra miliare del fundraising è la capacità di dare fiducia ai donatori sul fatto che le loro donazioni sono utilizzate per la causa che intendono sostenere. La fiducia informata è la più solida garanzia affinché risorse private e pubbliche possano sostenere i progetti delle organizzazioni no profit.
Se negli Stati Uniti e in altri Paesi fiducia e trasparenza sono garantiti per legge, attraverso tetti massimi prefissati alla spese di struttura, in Italia siamo ancora lontani da simili tutele. “É un dato di fatto che gli abusi in Italia sono purtroppo frequentissimi – commenta Zamagni. Io sono presidente dell'agenzia delle Onlus, dove non facciamo altro che dare parere positivo alla cancellazione dal registro di enti che vanno a fare la raccolta fondi spacciandosi per Onlus, quando invece non lo sono. Questo tipo di soggetti sono all'incirca 6.000, su un totale di Onlus registrate che ammonta approssimativamente a 80.000/90.000. Comunque il problema è che la fede pubblica viene umiliata. In Italia i donatori a distanza sono 60.000, i quali danno circa 260 euro all'anno per sostenere i poveri del Terzo Mondo, per un totale di 18.000.000 di euro annui. Ora, se anche nel nostro paese dovesse scoppiare uno scandalo, quelle 60.000 persone non daranno più niente, non solo alle false organizzazioni, ma a nessuno. La fiducia finisce, perché la gente andrà da amici e parenti a diffondere la voce e a scoraggiare ogni tipo di donazione”.
L’Associazione Italiana Fundraiser nel 2004 si è dotata di un Codice etico dei Fundraiser (.pdf). L’unico esempio di certificazione è costituito invece dal marchio “donare con fiducia” (video), rilasciato dall’Istituto Italiano della Donazione ai propri aspiranti soci, una volta superate fasi di controllo e verifiche ispettive da parte di commissioni di esperti su trasparenza, efficacia ed efficienza. Da più parti si avverte, in ogni caso, la necessità, anche in Italia come all’estero, di un Ente autorevole in grado di garantire, sulla base di rigorosi processi di verifica, che principi e regole siano osservati.
Bibliografia
Coen Cagli M., Manuale di fundraising: la raccolta fondi per le organizzazioni non profit, Carocci Ed., Milano, 1998
Rosso H. A. & Ass., Achieving excellence in fund raising, Jossey – Bass, San Francisco, 1991 - tradotto e riadattato in italiano nella seconda edizione H. Rosso, E. Tempel, V. Melandri, Il libro del fundraising, Etas, Milano, 2004
Burnett K., Friends for life. Relationship fundraising in practice, London 1996
Melandri V., Masacci A., Fund Raising per le organizzazioni non profit, Il Sole 24 Ore, Milano, seconda edizione 2004
AA.VV., Viaggio nel Fund Raising, Monti, Saronno, 2004
Melandri V., Zamagni S., La via italiana al fund raising: intervento pubblico, filantropia e reciprocità, in Economia e Management, n. 5, settembre-ottobre 2001
Farolfi B., Melandri V., Il Fundraising in Italia. Storia e prospettive, Il Mulino, Bologna 2008
Manson D., Melandri V., Il management delle organizzazioni non profit, Maggioli, Rimini, 1999
Documenti utili
Gli italiani e le donazioni – Rapporto Eurisko 2008 (.pdf)
Gli italiani e le donazioni di fine anno - IPR Marketing - gennaio 2009
Codice Etico di Assif: Sottoscritto dai Soci sottoscrivono al momento dell’adesione all’assocazione di professionisti italiani che svolgono attività di raccolta fondi nel settore nonprofit, il codice regolamenta, in particolare, i rapporti tra i soci, i rapporti con le organizzazioni nonprofit e gli altri enti beneficiari, i rapporti con i donatori, i conflitti di interesse.
(Scheda realizzata con il contributo di Francesca Naboni)
E' vietata la riproduzione - integrale o parziale - dei contenuti di questa scheda su ogni mezzo (cartaceo o digitale) a fini commerciali e/o connessi a attività di lucro. Il testo di questa scheda può essere riprodotto - integralmente o parzialmente mantenendone inalterato il senso - solo ad uso personale, didattico e scientifico e va sempre citato nel modo seguente: Scheda "Fundraising" di Unimondo: www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/Fundraising.