
www.unimondo.org/Notizie/Il-PNRR-investe-nell-istruzione-di-alto-livello.-E-l-Italia-239904
Il PNRR investe nell’istruzione di alto livello. E l’Italia?
Notizie
Stampa
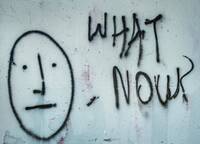
Foto: Tim Mossholder da Unsplash.com
Per aver puntato tutto sul “Made in Italy” nella produzione, nell’autenticità dei cittadini e anche nel linguaggio, il governo si macchia di “lesa inglesità” un po’ troppo spesso, specialmente negli interventi pubblici. Come dichiarato recentemente dal ministro agli Affari Europei Raffaele Fitto, il lavoro “positivo e costruttivo” con la Commissione Europea di rimodulazione del Next Generation EU (ovvero il famigerato PNRR in salsa italiana, il Piano Nazionale di Ricostruzione e Resilienza) passa attraverso il repowerEU, il piano europeo per rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del concordato 2030, stabilito dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tutto guarda alla liberalizzazione, alla competitività dei mercati globali, all’innovazione che passa dal “green” (consentitemi ancora un termine inglese) e dal digitale. Tutto sembra però rimanere incastrato in un collo di bottiglia fatto di burocrazia e di personale non qualificato a operare. I comuni, a cui spetta la proposta dei progetti e la loro attuazione, non hanno specialisti in grado di intercettare prima e gestire poi i fondi europei. Il funzionamento delle varie commissioni che devono seguire e autorizzare l’iter dei progetti è troppo lento rispetto al cronogramma di spese concordato con Bruxelles. Dalle dichiarazione delle ultime settimane emerge una generale condizione di improvvisazione sull’oggetto dei finanziamenti, che sembrano tener conto limitatamente delle indicazioni progettuali e dei fini ultimi del progetto, soffermandosi unicamente sull’esigenza di spendere.
Tra i capitoli di investimento del PNRR, una ghiotta fetta riguarda proprio un aumento di cittadini altamente formati, qualificati per poter poi operare anche nella pubblica amministrazione e nelle aziende in un’ottica generale di innovazione del Paese. Ecco quindi che il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha stanziato 18.770 borse di dottorato per l’anno 2023-24, in un investimento di oltre 726 milioni di euro. Il numero maggiore di borse sarà destinato ai cosiddetti dottorati innovativi con le imprese (nello specifico 13.292). L’obiettivo è quello di rispondere al fabbisogno delle imprese di professionalità altamente qualificate e specializzate e quindi di far convergere l’investimento del Ministero con quello privato a favore di uno specialista in grado di lavorare (e migliorare) la struttura produttiva, organizzativa, di posizionamento sul mercato dell’azienda. In un Paese popolato di piccole-medie imprese con base sociale familiare, un investimento in termini di ricerca e sviluppo è necessario. Che gli sgravi fiscali governativi messi sul piatto per la futura assunzione di personale con titolo di dottorato di ricerca (di cui si è finanziata la borsa di studio) siano elementi di interesse è tutto da vedersi. Al momento, gli Atenei italiani stanno dando comunicazione di questa possibilità alle principali realtà del tessuto economico del loro territorio, incrociando le dita per l’attivazione di tutte le posizioni di dottorato bandite. Tuttavia, più che uno stimolo al cambiamento, l’impatto immediato dell’investimento appare un nuovo collo di bottiglia generato da una nuova richiesta di personale in grado di gestire le pratiche con lo studente e la relazione con il privato aziendale.
Una domanda è d’obbligo: dove sta la visione strategica? Quella dettata dal PNRR di rinnovare il Paese rendendolo più green e digitale, diminuendo le disparità di opportunità tra territori e in base alle condizioni sociali di nascita, sembra rimasta sulla carta. Al di là dell’obbligo di garantire finanziamenti maggiori al Mezzogiorno, di fatto lo spazio dato alla co-progettazione e co-programmazione è stato minimo; i bandi indetti per i finanziamenti sono andati appannaggio di chi era già in grado di recepirli, con buona pace dell’intento di riduzione delle disuguaglianze.
E dove sta la strategia per il post PNRR? Alla fine del 2026 cosa ne sarà del personale amministrativo, dei ricercatori e degli altamente formati dottorati che il Piano ha consentito di stipendiare? Tutti destinati alla “fuga di cervelli”? Per un Paese come il nostro, con la quota di 30-34enni laureati pari al 26,8% contro una media europea del 41,6%, nonostante il trend positivo degli ultimi anni, i laureati fanno fatica a trovare un impiego adeguato ai loro studi (per competenze, stipendio e stabilizzazione). Per non parlare dei detentori del titolo di dottorato di ricerca “classico”: utilizzabile da normativa ministeriale solo per ricerca accademica, è messo nel cassetto in tutti gli altri casi. Paradossalmente consente di esser parte di commissioni di esami universitari e titolare di docenze accademiche ma non di insegnare nelle scuole primarie e secondarie; raramente poi è titolo di accesso per concorsi pubblici (generalmente rivolti a categorie con titoli di studio inferiori). Che i dottorati innovativi risolvano questa bizzarra situazione? Che si intenda veramente dare un senso a questo investimento in capitale umano?
C’è da dubitarne: bisognerebbe avere il coraggio di creare una strategia reale del “merito”, laddove per merito si intende un posizionamento in posizioni verticistiche per chi ha competenze al riguardo. Addio familismo amorale, quindi! Addio scelte di pancia o improvvisate! Largo a laureati, dottorati e chiunque altro abbia competenze affinate e aggiornate per rilanciare il Paese? Basta guardare alla stessa squadra di governo chiamata a trainare l’Italia nella gestione dei finanziamenti PNRR, delle cui competenze espresse (e dei pochi titoli nel cassetto) si sta già avvertendo il tremendo fracasso finale.
Miriam Rossi

Miriam Rossi (Viterbo, 1981). Dottoressa di ricerca in Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali, è esperta di diritti umani, ONU e politica internazionale. Dopo 10 anni nel mondo della ricerca e altrettanti nel settore della cooperazione internazionale (e aver imparato a fare formazione, progettazione e comunicazione), attualmente opera all'interno dell'Università degli studi di Trento per il più ampio trasferimento della conoscenza e del sapere scientifico.











