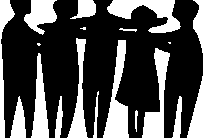www.unimondo.org/Paesi/Americhe/America-centrale/El-Salvador/Storia
Storia
Popolato in età precolombiana dalle tribù indigene dei Lenca e dei Pipíl, il territorio dell'odierno El Salvador fu occupato nel 1524 dal conquistador Pedro de Alvarado, uno dei luogotenenti di Cortés, che un anno dopo fondò la futura capitale, la città di San Salvador. Durante il dominio spagnolo El Salvador fece parte del Capitanato generale del Guatemala, che comprendeva oltre il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua e la Costa Rica, a sua volta ricompreso nel vicereame della Nuova Spagna (Messico). Nel 1811 scoppiarono nel Paese i primi moti nazionalistici, ma solo nel 1821 ebbe termine il dominio spagnolo. In quell'anno la Junta consultiva dell'ex Capitanato generale del Guatemala votò in favore dell'annessione delle province centroamericane al cosiddetto impero messicano di Agustín Iturbide. El Salvador fu la prima e la più inflessibile delle province a rifiutare l'annessione. La provvidenziale caduta di Iturbide (1823) evitò il conflitto con il Messico e nel 1823 El Salvador entrò a far parte della federazione delle Province Unite dell'America Centrale.
Seguì un periodo di torbidi e di anarchia cui El Salvador, divenuto il centro della resistenza liberale contro le tendenze conservatrici e autoritarie di cui era portatore il Guatemala, portò un notevole contributo, finché la federazione si sciolse (1839). La storia successiva del Paese che nel 1841 si era organizzato come Stato repubblicano indipendente fu caratterizzata dai tentativi di ricostituire un'unione con i Paesi vicini (in particolare con Honduras e Nicaragua, rispettivamente nel 1842-1844, nel 1849-1852 e nel 1862), tutti falliti per l'opposizione dei conservatori del Guatemala, col quale scoppiarono vere e proprie guerre nel 1844 e nel 1863. Nonostante l'avvento al potere nel Salvador dei conservatori, nuovi conflitti si aprirono nel 1885 e nel 1906 sempre con il Guatemala che, governato da un liberale dalla tempra forte e aggressiva come Justo Rufino Barrios (1873-1885), pretendeva di esercitare una leadership nell'istmo. In questo periodo la coltivazione del caffè per l'esportazione conobbe un grande impulso: i contadini indigeni subirono l'esproprio delle terre grazie ad alcune leggi che, proibendo il possesso comune della terra, favorirono l'acquisto della stessa da parte di una ristretta oligarchia borghese (le cosiddette 14 famiglie). Dopo la morte del guatemalteco Barrios che inseguiva il sogno di unificare la regione dell'istmo, di darle un governo liberale e di farle compiere alcuni passi verso il progresso i conservatori nel Salvador si consolidarono al potere e, pur tra le continue rivolte di generali che si succedettero al potere presidenziale, vi si mantennero fino al 1931. In questo stesso anno, in una situazione centroamericana di fatto completamente controllata dagli Stati Uniti, il generale Maximiliano Martínez, dapprima inviso a Washington, riuscì a impossessarsi con un colpo di Stato della presidenza del Salvador. Egli governò sopprimendo ogni tentativo di critica e di opposizione sino al 1944, allorché la ribellione di una parte dell'esercito fu soffocata così sanguinosamente che la piccola borghesia della capitale reagì con un lungo sciopero che paralizzò le attività pubbliche: il caudillo fu costretto a dimettersi. Al regime sanguinario di Martínez succedette il regime conservatore-militare del presidente Salvador Castañeda Castro.
La situazione nel Paese si andò sempre più deteriorando sia per motivi interni ai detentori del potere politico ed economico che si identificavano con i militari e l'estrema destra si opposero, infatti, diverse formazioni di guerriglia che avviarono una lotta armata sia per motivi esterni l'eventualità di una nuova Cuba o di un nuovo Nicaragua spingevano gli USA a intervenire per il mantenimento dello statu quo: la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta avevano infatti visto il moltiplicarsi delle azioni terroristiche e repressive condotte contro la stessa popolazione civile da organizzazioni paramilitari di estrema destra (gli "squadroni della morte") con evidenti legami con le forze armate (l'episodio più clamoroso fu l'omicidio del vescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, nel 1980), mentre alcuni gruppi guerriglieri di sinistra si erano uniti nel Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, dal nome di un leader comunista ucciso durante una fallita insurrezione nel 1932). Nel 1983, per tentare di risolvere una situazione ormai esplosiva, si costituiva il Gruppo di Contadora, formato esclusivamente da Stati latino-americani (Messico, Venezuela, Colombia, Panamá). Il 25 marzo 1984 vennero indette le elezioni generali, che videro la vittoria del candidato della Democrazia cristiana, il moderato José Napoleón Duarte.
Nonostante i propositi di pacificazione del neopresidente e la firma con Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicaragua nel 1987 degli accordi di Esquipulas (Guatemala) per una generale pacificazione in America Centrale, la guerra civile continuò con inalterata violenza. Il continuo peggioramento della situazione economico-sociale, il coinvolgimento di esponenti governativi in episodi di corruzione e la mancata attuazione della riforma agraria, avviata nel 1980 ma bloccata dagli interessi dei grandi proprietari terrieri, determinarono un netto calo di consensi per la Democrazia cristiana e la vittoria del candidato dell'ARENA, il conservatore A.F. Cristiani, nelle presidenziali del 1989.
L'avvento dell'estrema destra al governo provocò dapprima una radicalizzazione della guerra civile, ma, a partire dal 1990, la fine della guerra in Nicaragua, il radicale mutamento nei rapporti internazionali tra est e ovest e il connesso rilancio dell'azione delle Nazioni Unite sul piano regionale consentirono l'avvio di un processo di pace. Rappresentanti del governo e del FMLN condussero difficili negoziati e, grazie anche alla mediazione dell'ONU, concordarono una serie di riforme in campo militare, istituzionale ed economico-sociale. Nel gennaio 1992 furono firmati al castello di Chapultepec, a Città di Messico, gli accordi di pace; il conflitto si concluse formalmente, con una cerimonia ufficiale a San Salvador, il 15 dicembre 1992 dopo dodici anni, 75 000 morti, oltre un milione di profughi ed enormi danni economici.
La fine della guerra civile comportò un generale miglioramento delle relazioni con i Paesi vicini, mentre sul piano interno consentì una lenta ripresa economica, condizionata tuttavia dal persistere dei tradizionali squilibri; la politica neoliberista promossa dal presidente Cristiani favorì inoltre una ripresa degli investimenti privati ed esteri, senza però migliorare le condizioni di vita della popolazione. Quanto agli accordi di pace, la loro applicazione fu ampiamente disattesa: al dimezzamento degli effettivi delle forze armate non fece seguito la concessione di terre e alloggi alle unità smobilitate, né il riassorbimento di ex guerriglieri in un corpo di polizia civile, mentre l'approvazione di una legge di amnistia (1993) impedì l'epurazione dei militari colpevoli delle più gravi violazioni dei diritti umani.
Le prime elezioni del dopoguerra (1994) confermarono l'egemonia dell'ARENA, che ottenne la presidenza con A. Calderón Sol, mentre il FMLN, trasformatosi in partito politico, si impose quale principale partito di opposizione. Proveniente dall'ala più oltranzista del partito, il nuovo presidente impresse un'accelerazione al programma di privatizzazioni e inasprì la tassazione indiretta, suscitando un forte malcontento nell'opinione pubblica, già preoccupata da un vistoso aumento della criminalità comune, contro la quale Calderón lanciò una fallimentare "crociata". Nonostante le divisioni interne causate dall'emergere di una serie di scandali legati a episodi di corruzione e la minacciosa avanzata nei consensi per il FMLN, l'ARENA riuscì ad assicurarsi nuovamente la presidenza con l'imprenditore Francisco Flores, vittorioso alle presidenziali del marzo 1999. Tuttavia, nelle legislative dell'anno successivo per la prima volta gli ex guerriglieri ottennero la maggioranza relativa, superando l'ARENA anche nelle contemporanee consultazioni amministrative per eleggere il sindaco della capitale. Il nuovo governo dovette subito fronteggiare la disastrosa situazione causata da una serie di terremoti che, nel 2001, uccisero oltre 1200 persone e ne lasciarono senza casa circa un milione. Le elezioni legislative del marzo 2003 vedevano nuovamente la vittoria dell'FMLN, sanzionando la sconfitta dell'ARENA, che ha mantenuto tuttavia il controllo del Parlamento, alleandosi con le altre forze di destra. Gravi disagi sociali vennero provocati nel Paese dal lungo sciopero degli addetti al servizio sanitario nazionale. Le elezioni presidenziali del marzo 2004 venivano vinte da Elias Antonio Saca, candidato dell'ARENA, partito al governo, mentre il candidato dell'FMNL non arrivava nemmeno al ballottaggio. Nel marzo 2006 si tenevano le elezioni legislative nelle quali ARENA vinceva 34 seggi e l'FMNL 32.