
www.unimondo.org/Notizie/A-cosa-serve-l-altruismo-in-natura-221677
A cosa serve l’altruismo in natura?
Notizie
Stampa
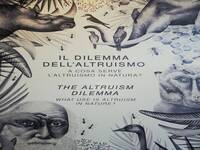
Foto: Anna Molinari ®
In un’epoca in cui essere altruisti è un’abitudine che a volte sembra davvero démodé, Daniela Gentile e Gabriele Raimondi si sono fatti una domanda: “A cosa serve l’altruismo in natura?”. Ne è nata una mostra, di cui loro sono curatori, che fino al 3 aprile 2022 sarà ospitata al MUSE – Museo delle Scienze di Trento per indurre i visitatori a porsi ulteriori, stimolanti questioni che spaziano dalla filosofia alla morale, dall’evoluzione ai comportamenti degli animali e, perché no, anche di noi umani. E arrivare probabilmente a una conclusione: la natura ha sempre e ancora molti suggerimenti da dare a noi che, anche se non possiamo fare a meno di crederlo, non siamo poi così speciali.
Già, perché per noi esseri umani l’altruismo è un concetto che porta con sé implicazioni molteplici: un’azione è altruistica se viene portata a termine con l’intenzione consapevole di aiutare qualcun altro – ma spesso si carica di altre valenze. Quella per esempio di stare bene sapendo di fare del bene, o quella di sentirsi utili, necessari, buoni. Esiste qualcosa di simile in natura?
L’altruismo nel mondo animale è un comportamento ancora dibattuto dagli scienziati e rimane in parte misterioso e di non facile circoscrizione, proprio perché sembrerebbe contraddire la teoria dell’evoluzione.Un grattacapo che già accompagnava Darwin, che proprio studiando i sistemi sociali degli imenotteri (api, vespe, formiche) si rese conto dell’esistenza di dilemma che poteva compromettere la sua teoria. Infatti, la presenza fra gli insetti di intere “caste” altruiste, che rinunciano ad avere una prole propria dedicando la vita al bene comune, era in disaccordo con il principio della selezione naturale del più adatto, dove “più adatto” definiva proprio l’individuo con il maggior successo riproduttivo.
La questione è rimasta cruciale perché nel tempo, proprio grazie a documenti e materiale raccolto da numerosi scienziati e ricercatori, ha aggiunto esempi di altruismo all’interno di altre specie – e anche tra specie diverse. Alcune di queste testimonianze sono presentate proprio nella mostra “Il dilemma dell’altruismo”, che ospita un progetto video-fotografico nato appunto dall’idea di Daniela Gentile e Gabriele Raimondi, corsisti del Master Fauna and Human Dimension. Un lavoro che integra interviste e immagini per una riflessione su diversi tipi di comportamenti altruistici: quelli cooperativistici, quando gli individui traggono un vantaggio immediato da un comportamento (alleanze nella caccia o nella difesa dai predatori) – si pensi alle sentinelle, per esempio tra i suricati e le marmotte, che si espongono un rischio più alto di essere uccisi dai predatori per avvisare gli altri componenti delle colonie di un pericolo nelle vicinanze; ma anche quei comportamenti all’insegna della reciprocità, quando un individuo si comporta in modo altruistico perché si aspetta di ottenere in seguito una ricompensa – è il caso per esempio dei macachi che fanno grooming, ovvero si spulciano per liberarsi dai parassiti e nel frattempo rafforzare i legami sociali nel gruppo.
Gli scienziati hanno cercato nuove spiegazioni evoluzionistiche che interpretino la selezione naturale in modo più complesso, analizzando molteplici fattori. Fra questi, per spiegare il senso di comportamenti altruisti, c’è anche l’empatia: un coinvolgimento emotivo che spinge gli animali sociali ad andare oltre il freddo calcolo dei costi/benefici delle loro azioni e che si manifesta anche tra individui di specie diverse. Emblematico il caso dei ratti, che superata con fatica la paralisi del “contagio emotivo” (se il mio consimile sente paura, quella paura paralizza anche me) negli esperimenti in laboratorio hanno dimostrato di saper raccogliere il coraggio sufficiente per mettere a rischio le proprie certezze e soccorrere un compagno intrappolato. Altrettanto peculiare il caso degli scimpanzé che consolano chi ha avuto la peggio in un conflitto, rinunciando alla scelta apparentemente più vantaggiosa di salire sul carro del vincitore e coccolando invece chi ha avuto la sorte peggiore.
Una spiegazione a questo mistero della solidarietà ha provato a darla con la matematica William Hamilton, che negli anni ’60 ha delineato una relazione tra l’altruismo e i rapporti familiari, formalizzandola nella cosiddetta kin selection (teoria della selezione di parentela) e basandosi sul presupposto che il fine ultimo, conscio o inconscio che sia, resti sempre e comunque quello di trasmettere i propri geni. Un obiettivo che può essere raggiunto in maniera diretta (generando figli propri) o in maniera indiretta, supportando cioè la riproduzione dei parenti stretti, geneticamente simili. La regola si esprime al suo massimo nei sistemi eusociali, nei quali una rigida divisione dei ruoli garantisce la salvezza del gruppo e la continuazione del patrimonio genetico condiviso. Si pensi non solo alle api, forse l’esempio più noto, ma anche alle formiche rosse, dove per esempio una casta di operaie sterili sincronizza l’espulsione di acido formico sopra il proprio nido per massimizzare l’effetto deterrente sui predatori e quindi salvare l’intera colonia. Comportamenti che altrove, per ora, si trovano solo negli esemplari di ratti-talpa come l’eterocefaloglabro, unico mammifero eusociale noto che riserva l’accoppiamento come prerogativa di un’unica regina e numerosi re all’interno delle proprie tane sotterranee, che contano circa 80 individui ciascuna.
Presso la mostra – che consiglio di visitare nelle fasce orarie di minor affollamento per poter goder al meglio anche del materiale video presente – sono ospitati anche gli interessanti punti di vista di Telmo Pievani (sul tema della filosofia della scienza e dell’evoluzione), Elisa Demuru (sugli aspetti dell’etologia) e di Giorgio Vallortigara (per quanto riguarda le neuroscienze), che offrono contributi da diverse prospettive utili a rendere la riflessione più articolata e complessa e non ridurla a una mera antropomorfizzazione di comportamenti che restano animali e quindi – per i traguardi raggiunti ad oggi dalla scienza – privi di aspetti morali che invece caratterizzano noi umani.
Insomma, una visita a questo focus sul mondo della natura è decisamente una buona occasione per incuriosirsi sugli animali ma anche per ripensarsi come uomini: dalle megattere che difendono altre specie marine dagli attacchi delle orche, investendo tanta energia e correndo il rischio di ferirsi gravemente,al tursiope con la spina dorsale deformata accolto in un branco di capodogli, forse – a fronte di motivi ancora non chiari – per il puro piacere di stare insieme da parte di due specie che condividono una forte socialità; dai picchi delle ghiande che a volte ritardano la propria riproduzione di qualche anno per aiutare i genitori ad allevare i fratelli più giovani al piviere del Pacifico che (come altre specie nidificanti a terra) si finge infortunato all’ala per distogliere il predatore dal nido e attirarlo verso di sé, alle femmine di camoscio che fanno da babysitter ai piccoli del gruppo per permettere a turno alle altre madri di riposare e mangiare, ogni cosa, in natura, ci ricorda che siamo parte di una rete: quel grande sistema interconnesso che si chiama ecologia.
Anna Molinari

Giornalista freelance e formatrice, laureata in Scienze filosofiche, collabora con diverse realtà sui temi della comunicazione ambientale. Gestisce il progetto indipendente www.ecoselvatica.it per la divulgazione filosofica in natura attraverso laboratori e approfondimenti. È istruttrice CSEN di Forest Bathing. Ha pubblicato i libri Ventodentro (2020) e Come perla in conchiglia (2024). Per la testata si occupa principalmente di tematiche legate a fauna selvatica, aree protette e tutela del territorio e delle comunità locali.









